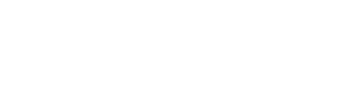Leggi l’articolo di Fabio Sattin su Il Sole 24 Ore
Cosa penserà il professor Mario Draghi del private equity e del suo potenziale contributo a supporto dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese? In questa fase di importante ridefinizione delle nostre politiche economiche e del Recovery Plan, è certamente una domanda che chiunque si occupi di tali tematiche si sta ragionevolmente ponendo e alla quale non è immediato dare una risposta. Bisognerebbe ovviamente chiederlo a lui. Tuttavia un’indicazione possiamo provare a ricavarla dalle Considerazioni Finali di Banca d’Italia del 31 maggio 2007, quando il professor Draghi ne era il governatore. A pagina 15 della relazione all’Assemblea ordinaria dei partecipanti, sul tema il professore dichiarava testualmente: «Gli intermediari specializzati nel capitale di rischio possono agevolare la crescita delle piccole e medie imprese, contribuire al rafforzamento della struttura manageriale, favorire l’accesso ai mercati di Borsa, accompagnare il ricambio generazionale».
In questo Draghi sembrerebbe quindi allineato con quella che è la tendenza internazionale che vede nell’attività di investimento nel capitale di rischio in società non quotate (i.e. private equity) uno strumento efficace a supporto delle imprese e dell’economia. Del resto, con oltre 94 miliardi di euro investiti nel 2019 in Europa in oltre 7.900 operazioni (Invest Europe, Private Equity Activity 2019), sarebbe curioso non fosse così. Indubbiamente un messaggio positivo per gli operatori del settore. Certo, sono passati molti anni da tale affermazione, ma considerata l’attenzione e la ponderazione che caratterizzano le dichiarazioni del Professore, in particolare se fatte in veste ufficiale, si potrebbe essere indotti a pensare che questa continui a essere la sua posizione in merito.
Inoltre, nelle sue Considerazioni finali il professore continuava: «La proprietà familiare è un asse portante del nostro capitalismo; l’identificazione dell’imprenditore con l’impresa è un motore di sviluppo. Proprio per questo sono essenziali gli strumenti che ne agevolino il ricambio, se necessario. Quando la proprietà familiare perde il gusto del rischio creativo, quando la ricchezza investita nell’azienda comincia a essere vista solo come fonte di rendite o di benefici privati del controllo, l’immobilismo proprietario può diventare un freno alla crescita dell’impresa, la avvia al declino. È allora che maggiore diviene per l’impresa il bisogno di questi intermediari; massimo il guadagno potenziale che tutti realizzerebbero con il cambio della guardia; massima, a volte, anche la resistenza dei proprietari».
In queste poche righe il professor Draghi sintetizza uno dei problemi fondamentali che frenano lo sviluppo economico del Paese, ora come allora. La gestione spesso troppo “familistica” (e non meritocratica) del ricambio generazionale e la scarsa apertura del capitale a terzi, condizione spesso necessaria alla crescita e indispensabile alla creazione delle grandi imprese, normalmente quotate in borsa, che da noi, come sappiamo, scarseggiano. Altro aspetto su cui il Professore intravedeva all’epoca un ruolo per il private equity, in quanto nel già citato documento dichiarava: «Vi è uno stretto legame tra la diffusione degli intermediari specializzati e lo sviluppo della Borsa. Oltre un terzo delle aziende italiane che si sono quotate tra il 1995 e il 2006 è stato assistito da operatori di private equity, ampliando un accesso al mercato borsistico che in Italia è finora rimasto per lo più limitato alle imprese di grandi dimensioni, ed è molto al di sotto, per capitalizzazione, rispetto agli altri Paesi industriali».
E anche qui, purtroppo, poco è cambiato, nonostante siano passati 14 anni da tale affermazione.
Una tematica quindi di estremo rilievo per la nostra economia, peraltro affrontata anche dall’ultimo libro di Roger Abravanel, Aristocrazia 2.0, che tanto sta facendo discutere, dove si sostiene che nell’assenza di grandi imprese (e, all’estremo opposto, di iniziative valide di venture capital) risiede uno dei principali freni allo sviluppo del nostro Paese, in sostanza fermo da quasi 40 anni.
Ecco quindi che l’attività di private equity, in tutte le sue sempre più articolate ramificazioni e modalità di intervento, può effettivamente dare un contributo molto positivo in termini di rinnovamento e crescita della nostra struttura imprenditoriale, in una logica meritocratica e di sviluppo, volta a creare competenze e dimensioni adeguate a competere a livello internazionale, dando peraltro ai giovani possibilità di sviluppo e di crescita. È noto infatti che le aziende di grandi dimensioni, normalmente operanti a livello multinazionale, sono in grado di fornire risorse e percorsi formativi adeguati alla valorizzazione dei giovani di talento e che hanno voglia di impegnarsi, con evidenti e importanti risvolti e ricadute non solo a livello economico e imprenditoriale, ma anche culturale e sociale.
C’è quindi da augurarsi che nella revisione in atto del Recovery Plan, che grazie alle ingenti risorse stanziate rappresenta probabilmente l’ultima grande opportunità che viene offerta al nostro Paese per poter impostare un percorso di rinnovata crescita e sviluppo, anche e soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni, si tenga conto di questo importante settore e si stabiliscano modalità di intervento a supporto delle imprese, oggi necessarie, in una sana logica di virtuosa collaborazione tra pubblico e privato, rispettosa del mercato e delle sue dinamiche, sfruttando al meglio e nell’interesse del Paese le competenze e le significative risorse, anche finanziarie, offerte dagli operatori attivi in questo settore, siano essi nazionali o internazionali.
(Presidente esecutivo e socio fondatore di Private Equity Partners. Professore a contratto di Private equity e venture capital, Università Bocconi)